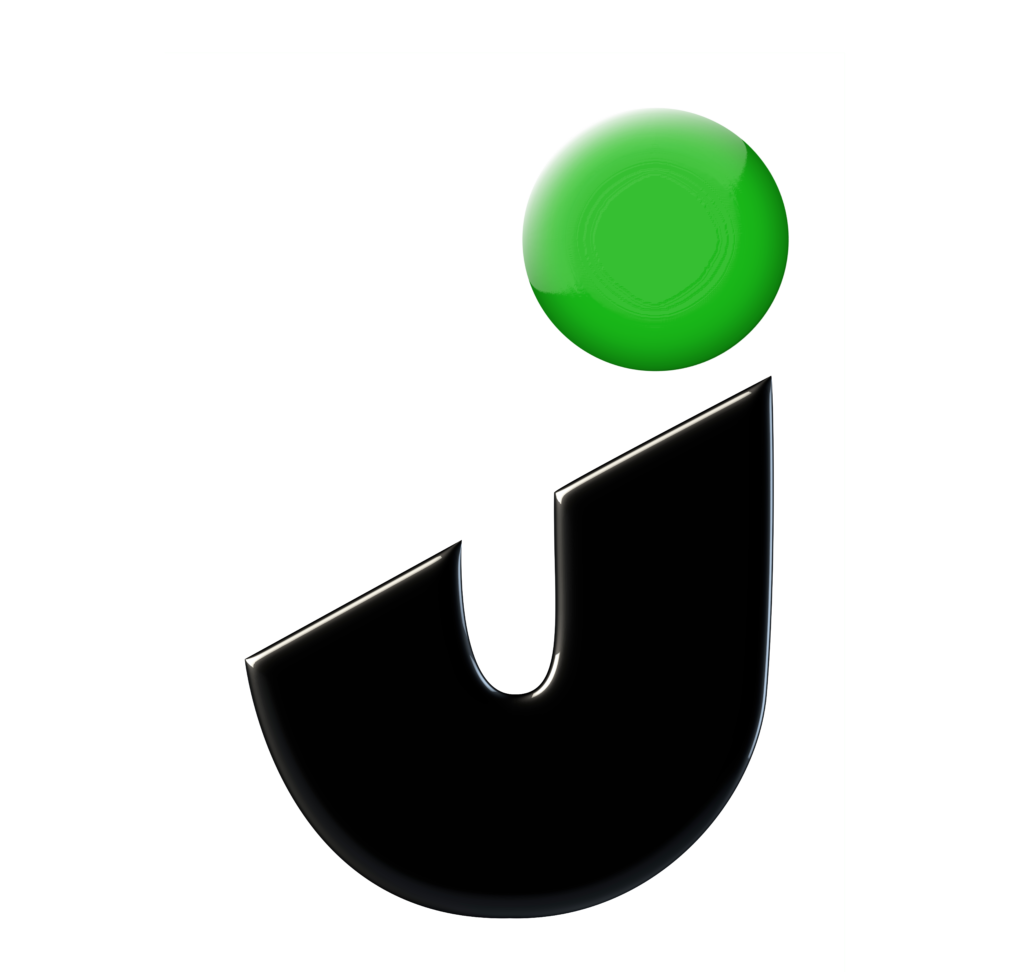CONVEGNO e MOSTRA – CENTRO STUDI JUDICARIA
LA DONNA NELLA PRIMA META’ DEL NOVECENTO IN GIUDICARIE
a cura di Elisa Polla
Perché il convegno e la mostra sulle donne “di una volta” in Giudicarie, figlie, mogli, madri e nonne? Abbondano le ricerche sui lavori tradizionali e sull’emigrazione maschile: arrotini/moléti, boscaioli, segantini, salumai, aisemponeri, spazzacamini, ombrellai, venditori ambulanti di vetri- maiolìni- di ceramiche ecc., ma meno indagato è stato finora il ruolo della donna nel periodo da fine Ottocento fino agli anni Cinquanta – Sessanta del secolo scorso. La Mostra intende far conoscere, soprattutto alle nuove generazioni, aspetti della vita sociale e delle famiglie, il lavoro agricolo, artigianale e l’emigrazione, i riti e le tradizioni nei nostri paesi della prima metà del secolo scorso, con una particolare attenzione al ruolo delle donne in quella società ormai tramontata, che vive solo nei ricordi dei più anziani.
Di questo periodo si è cercato di cogliere e riproporre quelli che sono i valori più autentici che ancora oggi costituiscono i fondamenti del nostro vivere quotidiano e che vogliamo difendere e trasmettere alle nuove generazioni; viviamo in un mondo globalizzato, ma abbiamo la convinzione che non debbano essere smarrite le nostre radici, che sia necessario coniugare il travolgente flusso di modelli esterni proposti dai mezzi di comunicazione e dalla mobilità delle persone con la solidità della nostra tradizione, con i valori della nostra storia. e, come si usa dire, mediare tra globalismo e localismo in nome di un sano “glocalismo”. Per evitare illusorie nostalgie e sentimentalismi vanno sottolineate le difficoltà, i disagi e i problemi che oggi sono stati almeno in parte superati e risolti: l’emigrazione, il lavoro minorile, la miseria, le fatiche immani per strappare alla terra qualche prodotto che consentiva spesso solo la sopravvivenza. Proprio su queste difficoltà le nostre ave e i nostri avi hanno costruito nel tempo i fondamenti di quella “cultura” che penso dobbiamo conoscere e conservare: la collaborazione, l’uso rispettoso del nostro territorio e l’amministrazione collettiva dello stesso, una volontà coriacea di affrontare le difficoltà con il
lavoro e con i sacrifici, lavorando la terra o emigrando, la solidarietà che caratterizzava la famiglia e in generale la comunità dei paesi. L’obiettivo del convegno e della mostra è quello di far riflettere, in particolare le nuove generazioni, su ciò che di positivo c’era in quel passato e che possiamo coniugare con il presente: riallacciare i fili spezzati formando, metaforicamente, con trama e ordito, un tessuto di Alta Qualità. La conoscenza della storia locale e delle tradizioni ha un’importanza fondamentale per la formazione dei giovani, poiché funge da ponte tra il passato e il presente, contribuendo a formare l’identità culturale e personale dei ragazzi. Immergendosi nelle storie delle proprie comunità, i giovani possono capire meglio le origini dei valori, delle usanze e delle pratiche che li circondano e apprendere valori come il rispetto per il patrimonio culturale e non solo e l’importanza della memoria collettiva. Inoltre, il rispetto per la storia locale promuove una maggiore consapevolezza critica, incoraggiando il giovani a riflettere su come il passato influenzi il presente e a farsi portavoce di un futuro consapevole e sostenibile. In un mondo sempre più globalizzato, dove le culture si intrecciano e si trasformano, preservare la conoscenza della storia locale diventa cruciale per delineare un futuro in cui i giovani possono essere non solo custodi del passato, ma anche interpreti di un presente che valorizza il legame con le proprie origini e aiuta a formare cittadini consapevoli e responsabili. La storia è maestra di vita? Lascio la risposta non semplicistica agli “addetti ai lavori”: qui poi l’oggetto del convegno e soprattutto della mostra è la “microstoria” delle Giiudicarie. Di certo la storia e la nostra microstoria oltre che fonte di conoscenza del passato è chiave interpretativa del presente e del futuro per il nostro territorio. La rievocazione di situazioni che hanno caratterizzato il nostro Primo Novecento è anche utile strumento di conoscenza e di confronto con altre realtà culturali con le quali ci stiamo confrontando in questi ultimi decenni.
E’ in questa civiltà rurale che le donne esercitano un ruolo importante non adeguatamente riconosciuto. Le Donne protagoniste della mostra, vissute in un periodo caratterizzato dalle due grandi guerre mondiali e da forti movimenti emigratori, non hanno mai permesso che mancasse l’indispensabile in casa, sacrificando tutto di loro stesse, praticando lavori come la filatura del lino, la lavorazione della lana, dalla tosatura della pecora al telaio, alla confezione e altre attività: cucire e rammendare anche per altre famiglie oltre la loro, andare a opera anche nei prati e nei campi. Loro non conoscevano il prezzo delle cose, ma il valore.
Una generazione che, senza aver mai studiato, ai figli ha insegnato i valori che tengono unite le famiglie: l’umiltà e l’Amore attraverso il sacrificio, e il rispetto. Donne che non hanno trascorso una vita agiata e non conoscevano il lusso, ma non per questo si
sentivano frustrate, resilienti si adattavano alla situazione del momento senza mai arrendersi, con dignità.
Vestite con indumenti sobri pesanti che realizzavano loro direttamente: dalla semina del lino e della canapa alla trasformazione, dall’estirpazione alla battitura della fibra, dalla filatura alla tinta dei filati e dalla tessitura alla confezione. Il vestito era sempre uguale per i giorni di lavoro; solo la domenica per la santa messa si cambiavano vestito indossato col grembiule semilucido di satìn e abbinavano accessori come lo scialle, spesso di seta, regalo di nozze del marito come pure la collana di corallo, un tempo quasi d’obbligo perché era un simbolo legato alla fertilità (riti e credenze). Durante la messa della domenica, talvolta, le ragazze se erano più sorelle, si scambiavano a turno le scarpe belle per andare alla comunione.
Poche cose e niente di superfluo, ma orgogliose di mostrare la loro immagine nel migliore dei modi.
La dote. A quei tempi era d’obbligo preparare la propria dote; le ragazze iniziavano alle elementari a ricamare, a dodici, quattordici anni erano già “brave di man”, una delle “virtù” che cercava la madòna- futura suocera, per il figlio, la donna brava anche a fare i lavori a mano.
Le ragazze erano brave a ricamare le lenzuola e la biancheria e le mamme aiutavano per gli ultimi ritocchi finali. I ricami erano molto curati ed elaborati ad intarsio e con molti tipi di punto a ricamo, veri capolavori: i giorni precedenti al matrimonio si usava mettere in mostra la dote che era esposta, per categoria, in uno scrupoloso ordine. C’era l’orgoglio di avere la dote più bella con tante lenzuola, in particolare ai tempi del “far lesiva” in comune: solo le famiglie povere lavavano spesso le lenzuola in modo spiccio, perché ne avevano poche.
La famiglia era sacra; anche l’educazione dei figli era a carico della mamma, “l’òm al nava ala guadàgna…” l’uomo doveva guadagnare il pane spesso lontano da casa come emigrante… e in questo caso la donna svolgeva anche i lavori dell’uomo.
Il tempo “libero” dai lavori fuori casa la mamma lo dedicava ai figli per i compiti di scuola e per catechismo che occupava ben due ore la settimana di lezione in classe ed il pomeriggio della domenica in canonica (oratorio).
Il parroco era consigliere di famiglia soprattutto per la donna; guidate dalla fede le donne consideravano le parole del prete di assoluta importanza per il loro comportamento morale nei confronti dell’uomo.
L’umiliazione più grande era quella che prima di mettere piede in chiesa, dopo quaranta giorni dalla nascita del bambino, la puerpera doveva essere benedetta fuori dalla chiesa perché considerata peccatrice.
Donne che, chi è ormai avanti negli anni, ha conosciuto come mamme o nonne e di cui ricordano le mani rovinate dal lavoro, in casa curve a pulire, con spazzoloni di saggina, i pavimenti di legno, a lavare i panni a mano, a far bügàda o far lisiva; quasi tutte avevano famiglie numerose.
Un lavoro faticoso, ma abituale, era anche quello di tostare e poi pestare l’orzo per il caffè nella pila (recipiente in granito) usando un pesto di ferro pesantissimo.
Le ricordiamo nei campi curve con le zappe, a seminare o a raccogliere patate, fagioli ecc… a spargere e rastrellare il fieno; facce scure per aver preso tanto sole, ma anche scure e rugose dalla grande stanchezza, mute silenziose, mai una lamentela nemmeno quando stavano male. E quando succedeva alle figlie le parole erano queste: “… fa vargùt ca ‘l ti pasa! Sa ti stè lì a scuftar tüt…” –… fa’ qualcosa che ti passa, se stai lì ad ascoltare tutto…- cioè il male non andava ascoltato, ma combattuto impiegando le energie in qualcosa di utile, nei limiti del possibile naturalmente…, ma l’essere spronati era un metodo di educazione efficace.
La riservatezza era il valore principale sia per le debolezze fisiche che per gli affari di famiglia.
Le ragazze: erano rare quelle che studiavano, molte fino agli anni 40 andavano in servizio, la maggior parte a Milano o in altre città, vita dura con tantissime situazioni, dalla nostalgia alla paura, allo sfruttamento in tutti i sensi, alla solitudine… si capisce dai vari racconti durante le interviste.
La vita sociale nei nostri paesi era per lo più quella di andare a udienze per i figli a scuola; anche la messa la domenica era un importante momento sociale, un incontro con tutta la comunità, uno scambio di notizie e di pareri su certe difficoltà comuni; gli uomini concludevano contratti e contatti a volte anche sul futuro sposo per la figlia.
Il cambiamento per la donna verrà solo gradualmente dopo la seconda guerra mondiale con il tramonto della civiltà contadina; le donne acquisiscono maggior coscienza delle loro capacità e con l’indipendenza economica iniziano a ricoprire ruoli sempre più rilevanti anche in ambito economico e poi sociale. In questo periodo in Giudicarie, in modo diversificato nelle varie zone, il mondo rurale subì importanti trasformazioni, che riguardarono dapprima la manodopera maschile con l’avvio dei grandi lavori idroelettrici e lo sviluppo dell’edilizia, poi anche le donne coinvolte nell’attività di nuove aziende industriali come pure di piccoli laboratori di maglieria e sartoria e del nascente turismo. In conseguenza di queste trasformazioni economiche e sociali si esaurisce il grande flusso emigratorio che aveva caratterizzato tutto il Trentino e in particolare le nostre valli a partire dalla metà dell’Ottocento. Qualche residuo fenomeno migratorio, perlopiù temporaneo, si è registrato ancora negli anni Sessanta, interessando la manodopera sia maschile che femminile.
Il convegno ha l’obiettivo di introdurre la mostra che si aprirà alle 18.
La mostra non ha la pretesa di essere completa, esaustiva: ci sono attività non rappresentate e i testi sono sintetici, danno alcune informazioni principali: tantissimi erano anche i lavori casalinghi e le sfumature e i modi diversi per ogni donna di eseguirli e molti sono stati i cambiamenti degli stessi nel corso degli anni.
L’obiettivo oltre che di fornire informazioni è di suscitare emozioni e di indurre a svolgere ulteriori approfondimenti e ricerche per fare luce sempre più completa sull’universo femminile, a riscoprire le radici, a pensare.
Conclusione
La mostra propone al visitatore una esposizione non solo di oggetti o attrezzi per la lavorazione della lana, del lino, della seta ecc…e della cucina in generale, ma anche gioielli che racchiudevano riti scaramantici …
La mostra è divisa in due sezioni in due sale distinte.
La prima sala è dedicata ai lavori in casa e in famiglia.
Sono esposti oggetti e strumenti delle operazioni che le donne svolgevano come attività quotidiana.
Teniamo conto che non esistevano elettrodomestici, che praticamente non esisteva esternalizzazione delle lavorazioni, che il riciclo, il riuso, l’adattamento era la regola. Anche l’acquisto di prodotti era ridotto al minimo indispensabile. Così la donna era impegnata in tantissime attività.
Lavori in campagna – Il lavoro nell’orto, la raccolta del fieno, l’approvvigionamento dei lavoranti di campagna.
La liscivia – Fare il bucato era nello stesso tempo pesante impegno collettivo e rito comunitario che durava giorni.
Filatrice, sarta, ricamatrice – Le donne eseguivano tutte queste attività nelle serate dei filò invernali, durante il giorno nei ritagli di tempo. Per qualcuna si trattava anche di attività lavorativa vera e propria, ma la generalità delle donne di famiglia con più o meno abilità, eseguiva lavorazioni relative al vestiario della famiglia, ma anche all’addobbo, alla biancheria della casa, alla dote propria o delle figlie
Cucina e cibo cioè la casalinga – Naturalmente rientra tra gli impegni quotidiani della donna. Comprende non solo il cucinare ma anche tutte le operazioni connesse alla preparazione delle vivande, la raccolta di erbe e frutti nelle campagne e della produzione di ortaggi. Il lavoro di casalinga non si limitava alle faccende domestiche come oggi intese; comprendeva la pulizia e la manutenzione dell’attrezzatura; basti pensare alla pulizia dei rami… e degli attrezzi degli uomini usati per la lavorazione del maiale, la macchina del salame ecc…
Educazione dei figli – Toccava alla donna in quanto gli uomini erano impegnati nei lavori di campagna, nelle case da monte, nelle malghe o comunque nelle lavorazioni artigianali.
I rapporti con la scuola e con il parroco toccavano in ogni modo alla mamma. Soprattutto le bambine, ma anche le adolescenti che non avevano già un lavoro, erano sotto il controllo della mamma. Fin dagli inizi del secolo spesso le adolescenti venivano mandate in città a servizio di famiglie agiate. Negli anni Cinquanta e Sessanta l’insediamento di qualche attività artigianale, di laboratori o di piccole industrie favorì il lavoro di operaie in zona; ma siamo già al tramonto della civiltà contadina e agli albori di una nuova fase economica che comportò una piccola rivoluzione culturale e sociale che si intensificherà con il forte impulso del turismo.
I figli maschi appena abili al lavoro spesso seguivano i padri talvolta ancora in età scolare.
Nella prima sala, dedicata ai “LAVORI IN FAMIGLIA” ai quali ho accennato, sono allestite due sezioni più propriamente appartenenti ai “MESTIERI”: si tratta del lavoro della levatrice e di quello della balia. Sono inserite in questo primo percorso perché sono particolarmente collegate al percorso famigliare.
La levatrice – In ogni paese c’era almeno una levatrice. I figli nascevano in casa con la collaborazione di altre donne di famiglia e con l’assistenza della levatrice.
Balia – Si tratta di una figura non diffusa nel nostro territorio. Molte donne svolgevano questa attività presso famiglie abbienti nelle città spesso abbinando questo nobile impegno a quello più umile della serva.
La seconda sala è dedicata ai “MESTIERI”, cioè alle professioni o attività che la donna svolgeva nella società. Ovviamente in alcuni casi la professione o il mestiere incrocia anche l’attività svolta per la famiglia. In particolare ciò succedeva per la sarta, per la ricamatrice, per la filatrice. Nel corso del Novecento queste figure presenti nei nostri paesi emergevano per la particolare abilità nello svolgere determinati lavorazioni, o per la situazione famigliare in cui l’attività di madre era ridotta, per il limitato numero dei figli, oppure quando i lavori di campagna erano scarsi, o nei casi in cui l’attività dell’uomo di famiglia era diversa (artigiano, emigrante ecc.).
Medica – … fino agni anni ’50 da noi non c’erano le dottoresse, ma si legge da documenti storici che le prime erano farmaciste e chiamate mediche, ma avrete modo di leggere poi le spiegazioni sui cartelloni esposti…
Infermiera – attività ospedaliera, raramente c’era nei paesi, ma talvota andava anche a domicilio a fare le iniezioni….
Maestra – Ancora alla fine dell’Ottocento il numero delle maestre delle scuole popolari erano numerose al pari degli uomini. Il loro trattamento economico era molto inferiore a quello dei maestri che spesso affiancavano a questo impegno altri lavori impiegatizi (nei comuni, nelle poste ecc.).
In quel periodo alle maestre veniva proibito il matrimonio, dato che si chiedeva loro una completa dedizione alla “missione” di maestra, che il matrimonio e la cura dei figli avrebbe impedito o quantomeno limitato. La norma venne abrogata e superata, seppure tra diverse resistenze, sul piano legislativo, ma rimase per decenni ancora durante il Novecento la convinzione che una mamma non potesse essere anche una buona maestra.
Negoziante – … Serva – … Suora – … non vi anticipo perché poi potrete leggere tutto nella mostra.
Non possiamo trascurare come “impegno straordinario” quello delle donne in guerra. Anche nelle Giudicarie, soprattutto nei paesi che erano sulla linea del fronte nella Prima Guerra, in Rendena e nella Valle del Chiese, furono impiegate quali portatrici di assi e altro materiale per la costruzione di baracche sul fronte adamellino e su quello del Càdria e del Nòzzolo. Gli uomini abili erano in guerra sul fronte orientale e le donne oltre che sostituirli nei lavori di campagna dovettero sobbarcarsi questo duro impegno per mantenere figli e anziani rimasti interamente a loro carico.
Esistono toccanti testimonianze delle quali ho riportato un esempio nella mostra. Il Centro Studi Judicaria ha curato una pubblicazione sull’argomento.
Credo non potesse mancare in questa occasione portare all’attenzione le lavorazioni che hanno caratterizzato il lavoro delle donne nel periodo che è oggetto del convegno e della mostra.